I ritardanti di fiamma sono sostanze che provocano un notevole rallentamento e talvolta l’estinzione della fiamma. Quello di maggiore impiego, soprattutto per le materie plastiche a base di poliolefine e di cloruro di polivinile, è l’idrossido di alluminio, in virtù del suo basso costo e della facilità a essere incorporato dentro i materiali polimerici. L’effetto di estinzione della fiamma è dovuto al fatto che a circa 180-200 °C l’idrossido di alluminio si converte in ossido tramite la reazione 2Al (OH)3→Al2O3+3H2O−298 kJ/mole. (Enciclopedia Treccani)
Chi lavora a stretto contatto con materie chimico-plastiche, elettroniche o tessili, conosce perfettamente l’impiego e la funzione dei ritardanti di fiamma (FR).
Tuttavia, spesso si ignora che queste sostanze hanno un notevole utilizzo anche in campi inimmaginabili e che l’organismo umano ne entra in costante contatto, durante l’intero arco della giornata.
L’uso dei FR, infatti, risale al 484 a.C. (quando lo storico greco Erodoto documentò l’uso di potassio e solfati di alluminio da parte degli egiziani, come ritardanti di fiamma per ammollo del legno).
Esiste una diversa e specifica classificazione per i diversi ritardanti di fiamma, ma la più recente del 2020 suddivide i ritardanti in:
- minerali: sono in genere additivi, come idrossido di alluminio e di magnesio;
- organo-alogeni/organo-fosforici: possono essere sia additivi sia reattivi:
- Organoalogeni: organoclorurati, organobromine (BFR) come decabromodifenil etere (decaBDE), difenil eteri polibromurati (PBDE). Questi composti possono anche essere definiti come “Composti di Organobromina“ovvero contenenti carbonio legato al bromo.
- Organofosforici: organofosfati (OPFR) come trifenil fosfato (TPP), resorcinolo bis (difenilfosfato) (RDP), bisfenolo A difenil fosfato (BADP) e tricresilfosfato (TCP). Un caso particolare è il tris (1,3-dicloro-isopropil) fosfato (TDCPP), studiato nell’impatto sul sistema endocrino.
Tra i più utilizzati, compaiono gli OPFR (dato che i BFR e i PBDE sono stati gradualmente eliminati dal mercato a causa dell’elevata tossicità), la cui composizione non è esente da numerose criticità.
Già nel XX secolo gli OPFR erano parecchio utilizzati; dopodiché, dal 1940, la produzione e il consumo di questi specifici organo-fosfati è aumentata rapidamente.
Secondo le statistiche di mercato, il consumo globale di OPFR è aumentato da 200.000 a 500.000 tonnellate dal 2004 al 2011, fino a toccare quota 680.000 tonnellate nel 2015. Dunque, il contatto con l’organismo umano è inevitabile.
In particolare, una revisione dei CE (le marcature di conformità obbligatorie per tutti i prodotti) ha dimostrato che gli OPFR sono ampiamente utilizzati in:
- mobili;
- tessuti e abiti;
- materiali da costruzione;
- elettronica;
- prodotti chimici;
- lucidi per pavimenti,
- rivestimenti, tecnopolimeri e resine epossidiche.
Grado di tossicità degli OPFR
Rispetto ai predecessori, gli OPFR hanno una composizione biologica meno persistente, ma a causa del loro uso diffuso, sono stati riscontrati nell’atmosfera, nel suolo, nell’aria artica e nelle acque superficiali dell’oceano.
Tra quelli in commercio, infatti, alcuni sono volatili e, quindi, vengono scaricati nell’aria con molta più facilità. Inoltri, quelli clorurati hanno una migliore solubilità in acqua e rappresentano una continua minaccia per gli animali acquatici.
Quasi tutti gli OPFR prodotti nell’ultimo decennio sono stati rilevati in animali marini e d’acqua dolce, pollame, insetti e campioni umani. Alla luce di queste evenienze, gli OPFR sono stati identificati come inquinanti emergenti. Inoltre, per gli OPFR, non esiste un metodo efficace di eliminazione completa.
Come si rivelano i residui di FR nell’ambiente
Le statistiche che rivelano i residui di FR nell’ambiente non vengono stilate a caso, ma sono frutto di ricerche specifiche e ben strutturate.
Tra le più utilizzate, gli studiosi prediligono la Spettrometria di cromatografia liquida-massa (LC/MS),
un metodo che evita le lunghe fasi di misurazione della concentrazione/arricchimento del campione. Si tratta di un metodo veloce, facile da usare ed estremamente affidabile.
Le richieste sempre più pressanti relative all’utilizzo di materiali a minor impatto ambientale, unite alla sempre maggior attenzione ai fattori di rischio per l’uomo in caso di incendio, rendono quello dei materiali ritardanti di fiamma uno dei campi di ricerca industriale più attivi.
Nonostante questo, molte formulazioni sono ancora basate su sistemi di “vecchia generazione”, di sicura efficacia e con costi relativamente contenuti, anche perché, purtroppo, la certificazione di nuovi sistemi FR è un processo relativamente lungo e costoso, due fattori che rappresentano sicuramente un freno per la ricerca e sviluppo nel settore.
Ritardanti di fiamma a basso rischio ambientale
Tuttavia, non tutti i ritardanti di fiamma costituiscono un rischio per la salute. Le nuove tecnologie, infatti, permettono di produrre FR a bassissimo impatto ambientale e, anzi, consentono anche di ridurre la tossicità di combustione dei materiali in caso d’incendio.
Secondo un test del National Bureau of Standards (Istituto nazionale di standard e tecnologia), infatti, alcune materie plastiche senza FR sono risultate molto più tossiche di materiali con ritardanti: confrontando la combustione di materiali con e senza FR, infatti, è emerso che i materiali FR consentono tempi di fuga più lunghi, meno rilascio di calore, meno fumo e soprattutto rilascio di una concentrazione inferiore di gas tossici.
I dati emersi, sorprendentemente, testimoniano come un tessuto con FR, seppur richiedeva una grande fonte di accensione per incendiarsi, rimanendo intatto, riduceva l’emissione di gas tossici, mentre le barriere con schiuma infiammabile aumentano di gran lunga l’emissione tossica (in condizioni di fiamma libera ridotta).
Dunque, per essere certi di tutelare la salute propria e altri, nonché il benessere dell’ambiente in cui viviamo, è necessario affidarsi a partener esperti, che producano materiali ritardanti all’avanguardia.
Alpha Micron, partner italiano del centenario Gruppo Alpha, è tra i più all’avanguardia nel settore.
Per ridurre al massimo il rischio di tossicità dei componenti, infatti, il Gruppo Alpha ha creato ALFRIMAL®, la soluzione ecologica, atossica e funzionale per ritardare la combustione dei prodotti.
Alfrimal, infatti, è atossico, sostenibile e certificato. Inoltre, grazie alla navigata esperienza del team Alpha Micron, puoi ricevere una consulenza e co-progettazione specifica per le tue esigenze.
Per scoprire come tutelare la tua azienda, evitando d’avvelenare te stesso e l’ambiente in cui vivi, clicca qui e ricevi una consulenza senza impegno dai nostri esperti
 Oswald Zimmerhofer
Oswald Zimmerhofer
Direttore generale

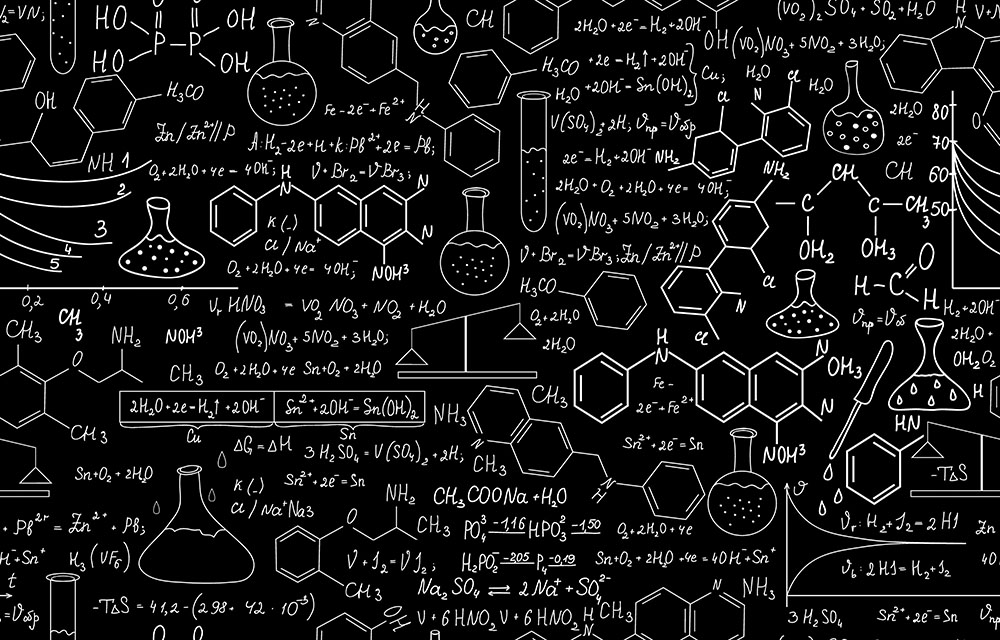


contattateci per info. Grazie